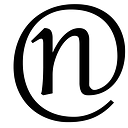Le istituzioni devono garantire spazio all’associazionismo di comunità
Una versione leggermente diversa di questo articolo è stata pubblicata da Animazione Sociale nel numero 9 della collana Matite (2022). L’articolo è la somma di una serie di riflessioni che ho maturato nei cinque anni di lavoro presso l’Assessorato ai Diritti della Città di Torino (2016–2021). La strategia interculturale e antirazzista qui delineata non è sopravissuta al cambio di giunta (2021): ritengo comunque che gli spunti contenuti in questo articolo possano essere utili ad altrə policy maker. Come sempre, feedback, commenti e riflessioni sono benvenuti, qui sotto oppure su Twitter a tw/@orpheo85
Per più di un decennio, la Città di Torino ha fondato le sue politiche interculturali sul rapporto con le cosiddette associazioni di comunità, cioè quelle associazioni la cui membership è basata essenzialmente su una comune appartenenza etnica, culturale o religiosa [questa definizione è preferita a quella, più classica, di “associazioni di migranti”: sempre più spesso, infatti, queste realtà includono persone appartenenti a seconde o terze generazioni che non sono mai “migrate” in vita loro].
Un primo passo è stato compiuto in una delibera del 2010, in cui l’amministrazione comunale si poneva come “specifico obiettivo delle politiche cittadine l’opportunità di valorizzare un patrimonio di socializzazione e un potenziale di progettualità e partecipazione sociale [delle associazioni di comunità]”. Lo stesso approccio è stato poi ripreso e reso strategico con l’approvazione delle “Linee guida per il coordinamento alle politiche per l’interculturalità della Città di Torino” nel 2018.
Alla base di entrambi i documenti vi è la consapevolezza che nessuna politica di inclusione può essere efficace se non coinvolge portatori e portatrici di interessi e bisogni nelle fasi di progettazione, implementazione e valutazione. Per dirla in un tweet:
occorre lavorare con e non per le comunità target.
L’approccio partecipativo è d’altronde condiviso e consolidato a livello internazionale. ECCAR, la Coalizione europea di città contro il razzismo, lo prevede nel suo Toolkit per la costruzione di politiche di contrasto alle discriminazioni; la rete Intercultural cities del Consiglio d’Europa sottolinea in un volume del 2009 che la “consultazione e partecipazione delle comunità nello sviluppo, messa in atto e valutazione della strategia interculturale non è solo importante in sé, è essenziale per il suo successo. Una città genuinamente interculturale può essere costruita solo attraverso la partecipazione attiva di tutte le maggiori istituzioni, comunità, gruppi del contesto urbano” .
Un coinvolgimento inclusivo e plurale
Ovviamente, passare dalla teoria alla pratica comporta una serie di difficoltà: come si coinvolge in processi democratici e partecipativi un’intera comunità, composta da migliaia o decine di migliaia di persone (spesso, peraltro, prive del diritto di voto o di altri strumenti di partecipazione democratica)?
Negli ultimi decenni, numerosi Paesi hanno tentato strade diverse per costruire relazioni con le comunità straniere sui territori: la cooptazione o l’elezione di figure “rappresentative” delle comunità; la costruzione — eterodiretta da parte delle istituzioni — di assemblee (le “consulte migranti”, diffuse anche in Italia una ventina di anni fa), la federazione delle associazioni di comunità straniere in enti riconosciuti formalmente, e altre modalità ancora.
Nel porre le associazioni di comunità al centro delle politiche, il Comune di Torino ha evitato sia di designare dei referenti unici sia di dirigere dall’esterno improbabili percorsi di accorpamento, puntando piuttosto al coinvolgimento inclusivo e plurale di tutte le realtà afferenti alle comunità.
In questo articolo cercherò innanzitutto di chiarire perché il Comune di Torino abbia deciso di focalizzare le energie sullo sviluppo delle associazioni di comunità e, in seconda battuta, quali lezioni sento di aver appreso durante i cinque anni (2016–2021) trascorsi come referente delle politiche interculturali cittadine, nella speranza che possano essere di ispirazione per altre autorità pubbliche.
Non basta la politica del cous-cous
Le persone appartenenti alla maggioranza bianca tendono ad associare le realtà di comunità a ciò che vedono, e quindi all’organizzazione di eventi, cene etniche, concerti e altre attività utili a far conoscere le culture straniere sul territorio. Per molto tempo, le politiche interculturali partivano dal presupposto che il razzismo e la discriminazione fossero basati sull’ignoranza e che, quindi, i progetti votati a creare ponti fra le culture (e le persone) sarebbero stati sufficienti a superare le difficoltà di integrazione/accoglienza e a costruire una società più consapevole, automaticamente più equa.
Intendiamoci: questa parte delle politiche interculturali è stata ed è enormemente importante. L’organizzazione di momenti conviviali e di scambio (se vogliamo banalizzare, la famosa “politica del cous-cous”), così come la presenza delle autorità pubbliche alle ricorrenze religiose o laiche di comunità (il capodanno cinese, la preghiera di fine Ramadan, la festa delle luci Diwali, ecc.), sono atti politici potenti e devono continuare a essere perseguiti. La diversità va resa visibile e celebrata.
Intercultura o antirazzismo?
Quello che è importante sottolineare, però, è che
l’ignoranza e gli episodi di razzismo individuale che ne conseguono sono solo la punta più visibile di un’enorme, più sistematica e strutturale discriminazione che le comunità razzializzate subiscono.
Non a caso, accanto a quella di mediazione, le associazioni di comunità svolgono altre due funzioni: il supporto e la partecipazione.
Innanzitutto, le associazioni di comunità aiutano a sopperire alle carenze di un welfare strutturalmente escludente: le persone straniere o razzializzate incontrano ostacoli linguistici, culturali, informativi o basati sui pregiudizi di operatori e operatrici quando si rivolgono a servizi e uffici pubblici. Alcune volte, inoltre, l’esclusione da alcuni benefit deriva da precise (e consapevoli) scelte politiche: ne sono un esempio i requisiti escludenti per l’accesso a determinate graduatorie, come un numero di anni ingiustificabilmente elevato per ottenere il reddito di cittadinanza o, in alcune Regioni, l’iscrizione alle graduatorie per gli alloggi popolari, o gli adempimenti burocratici riservati inspiegabilmente solo allə stranierə (come il requisito di idoneità abitativa per la residenza).
Si tratta di casi di razzismo istituzionale, cioè di forme di esclusione operate da amministrazioni pubbliche per inadeguatezza o per design, e che per di più colpiscono fasce della popolazione mediamente più fragili. A sopperire a questi deficit (nei limiti delle loro capacità) sono spesso le associazioni di comunità, che attraverso percorsi di mutuo aiuto permettono a individui e famiglie di affrontare difficoltà economiche, di salute, scolastiche, burocratiche. Fra i molti esempi in cui mi sono imbattuto, ricordo i servizi informali di orientamento per il disbrigo di pratiche burocratiche (chi può spiegare allə nuovə arrivatə come ottenere un certo documento meglio di chi ha appena percorso la stessa trafila?) e il supporto economico volto a sostenere spese e costi imprevisti, come quelli relativi a una riparazione domestica, a una bolletta, a un funerale.
Un ruolo simile a quello delle società di mutuo soccorso
Per la grande maggioranza dellə stranierə (con l’eccezione dellə cittadinə Ue), inoltre, i sindacati e l’associazionismo sono gli unici strumenti di cittadinanza attiva — e non è difficile immaginare perché un’organizzazione della propria comunità risulti spesso la soluzione preferita. Questa associazioni si trovano quindi a portare avanti istanze e interessi collettivi nel dibattito politico. Come sottolinea Sardinha nel paper Immigrant Associations. Integration and Identity (2009),
mentre è normale che le associazioni di migranti siano fondate per preservare l’identità e la cultura [di origine], inevitabilmente esse finiscono per giocare un ruolo fondamentale nel processo di integrazione dei propri componenti.
Nel compiere questa duplice funzione, le associazioni svolgono per le comunità di riferimento un ruolo simile a quello che le società di mutuo soccorso e i sindacati avevano nei confronti della classe operaia nel corso dell’Ottocento (e di parte del Novecento). Parliamo spesso di “ponti”, quando ci riferiamo alle realtà di comunità, ma è una metafora che ci viene in mente perché le guardiamo dalla nostra prospettiva. L’associazionismo delle comunità fa molto di più: è rete di sicurezza e valvola di sfogo, network di conoscenze, server per lo smistamento di informazioni e spazio di elaborazione di istanze che vengono poi portate all’opinione pubblica e alle istituzioni.
Una strategia lungimirante
In questo senso, la decisione del Comune di Torino di puntare in modo sistematico alla relazione con le associazioni di comunità è stata strategica e lungimirante.
Nei prossimi dieci o quindici anni, infatti, le istituzioni pubbliche — in particolare quelle locali — si troveranno davanti a una sfida colossale: recuperare il tempo perduto e mettersi al passo con i cambiamenti demografici degli ultimi trent’anni, ridisegnando in un’ottica interculturale se stesse, il proprio funzionamento e i propri obiettivi.
La costruzione di politiche trasformative richiede però di tenere in considerazione due dimensioni: quella individuale, più appariscente, e quella sistemica, più tecnica (ma altrettanto, se non di più, importante).
Più persone con background migratorio nei ruoli pubblici
Il primo livello riguarda l’aumento di persone non bianche fra le fila di amministratori e amministratrici della cosa pubblica, nelle scuole così come negli ospedali. L’incremento del numero di persone con background migratorio negli uffici e fra le cariche elettive è un obiettivo importante da perseguire perché è in grado di modificare l’immaginario e la percezione con cui intere generazioni di italianə guardano a se stessə e allə propriə coetaneə: di riscrivere, per dirla con l’esperto di narrazioni politiche Drew Westen, le regole di “cosa è, cosa potrebbe essere, e cosa dovrebbe essere”.
La presenza di figure appartenenti a minoranze (donne, persone lgbt+, persone con disabilità, giovani, ecc.) in posizioni apicali e di grande visibilità è sicuramente utile a rompere stereotipi e pregiudizi (grazie a quello che Simon Burgess, professore di economia presso l’Università di Bristol, chiama “effetto Michelle”). Ma la visibilità dei singoli rischia di diventare tokenism, cioè di risolversi in concessioni simboliche (come l’assunzione o l’elezione di una donna in un contesto di potere che rimane patriarcale), se non mette in discussione le strutture di potere.
Il coinvolgimento delle comunità razzializzate nella costruzione delle politiche pubbliche
Il cambiamento deve essere più profondo e sistemico: allestire degli spazi e degli strumenti per cui le comunità razzializzate siano coinvolte in tutte le fasi della messa a punto delle politiche pubbliche.
- Nel loro design, riportando necessità elaborate tramite una discussione collettiva e tradotte in richieste politiche nei confronti delle istituzioni.
- Nella loro implementazione, evitando il meccanismo per cui le comunità straniere e le loro associazioni sono sempre e solo “beneficiarie”, mentre il ruolo di partner (e destinatarie di fondi) spetta sempre e solo alle cooperative “bianche”.
- Nella loro valutazione, per poterne valutare l’efficacia in base all’impatto sulla vita della comunità.
L’obiettivo strategico è quello di riscrivere il patto sociale per la redistribuzione delle risorse e di avere le comunità al tavolo di discussione con pari legittimità e dignità con gli altri interlocutori.
Una strada né lineare né semplice
La strada perseguita per dieci anni dalla Città di Torino non è stata lineare né semplice, ma il modo in cui Comune e comunità hanno affrontato assieme l’emergenza Covid mi ha convinto della validità delle azioni intraprese.
Sono consapevole del fatto che nessuna strategia si può semplicemente esportare in un altro contesto e che città dalle dimensioni (soprattutto quelle più piccole, colpevolmente dimenticate nelle narrazioni sull’inclusione e nelle progettualità di contrasto al razzismo), dalla demografia e dalla struttura sociale diverse da quelle di Torino avranno bisogno di strumenti ad hoc. Spero comunque che questo breve compendio possa essere utile per suscitare delle riflessioni e dei ragionamenti: ne abbiamo urgente necessità.
La strutturazione di spazi richiede tempo e lavoro
Primo: l’allestimento di spazi e le modifiche strutturali richiedono tempo.
Le politiche interculturali non si improvvisano e la costruzione di una relazione con le associazioni e con lə loro referenti hanno bisogno di anni di lavoro paziente e sistematico.
Quando l’epidemia di Covid è scoppiata, associazioni e istituzioni si sono cercate perché c’era l’abitudine a farlo e si sono trovate perché i contatti erano già stabiliti.
Ovviamente, questo non dovrebbe demoralizzare le amministrazioni che si sentono di adottare questo approccio; in fondo, come sosteneva Confucio,
il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa; il secondo momento migliore è adesso.
Ma visto che la volontà di cambiare alcune regole del gioco richiede tempistiche maggiori di quelle concesse dalla politica elettorale, il coinvolgimento degli uffici e del personale amministrativo degli enti locali è fondamentale sin dall’inizio, così come la messa in sicurezza di alcuni percorsi tramite convenzioni, protocolli d’intesa, patti e altre forme giuridiche che possano impegnare le amministrazioni in un percorso pluriennale.
L’allestimento di Tavoli dove costruire insieme
Secondo: occorre costruire strumenti e piattaforme per valorizzare la fase di co-progettazione, cioè quella in cui, a partire dalle necessità delle comunità, l’amministrazione e i suoi interlocutori progettano azioni di inclusione e di welfare.
La Città di Torino ha utilizzato largamente i Tavoli di comunità: coordinamenti convocati regolarmente a cui venivano invitatə tuttə lə portatori e portatrici di interessi e bisogni afferenti a una specifica comunità. L’allargamento a tutti i soggetti era resa necessaria per
- evitare forme di clientelismo: se l’amministrazione dialoga con un unico referente per comunità, infatti, quella persona potrebbe acquisire un ruolo (e un potere) eccessivo nel far arrivare (o nel bloccare) determinate istanze all’ente pubblico. Inoltre, quale policy maker resisterebbe alla tentazione di dialogare solo con quellə referenti che trova più concilianti, più “ragionevoli”, con cui si sente più in linea — perdendo così di vista le voci più discordanti (spesso quelle maggiormente in fdifficoltà) delle comunità?
- Indebolire dinamiche di potere interne alle comunità: genere, orientamento, età e classe sociale giocano un ruolo anche all’interno dei microcosmi comunitari. Anzi, per certi versi, sono più importanti, in quanto intevengono in una realtà più ristretta: quando le comunità vengono rappresentate da una sola persona (e gli esempi nel Regno Unito e in Germania non mancano), si tratterà nella stragrande maggioranza dei casi un uomo di mezza età, eterosessuale e con un livello culturale ed economico più alto della media della comunità che “rappresenta”.
Lavorare per creare spazi di partecipazione inclusivi per quanti più soggetti possibile permette invece di ascoltare le voci delle minoranze nelle minoranze: donne, giovani, persone con meno strumenti culturali o possibilità economiche, persone lgbt+. Solo in questo modo è possibile mantenere un vero e proprio approccio intersezionale.
Le risorse in gioco e il razzismo istituzionale
Un terzo punto riguarda la fase di implementazione e, più nello specifico, la questione delle risorse. Fingere che non sia un tema sarebbe ipocrita:
non è possibile tessere una società realmente inclusiva se le comunità vengono viste unicamente come beneficiarie e mai come partner.
Inoltre, sebbene esistano in casi singoli delle oggettive debolezze strutturali nelle associazioni di comunità che rendono loro più difficile la gestione di un finanziamento pubblico, nella stragrande maggioranza la loro esclusione ha direttamente a che fare con forme di razzismo istituzionale o sistemico.
I bandi e i regolamenti sono pensati per un associazionismo professionista e bianco e raramente tengono conto delle differenze culturali. Un caso su tanti: un’associazione che, fra le altre cose, gestisce una moschea verrà sistematicamente esclusa da finanziamenti pubblici e privati perché considerata un ente religioso e, allo stesso tempo, esclusa dall’8permille in quanto l’Islam non è riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano.
Le categorie culturali — e quindi normative — con cui sono costruiti i bandi di finanziamento sono basati su una storia, un diritto e una cultura politica che non sono condivisi: se pure è impossibile per un Ente locale prescindere dalla normativa nazionale, un’attenzione specifica andrebbe dedicata a rivedere almeno quei requisiti più esplicitamente etnocentrici.
Riconoscere alle comunità uno status progettuale di partner alla pari permetterebbe, inoltre, di combattere una pericolosa deriva: quella del cosiddetto razzismo benevolente. Nel loro saggio sugli Spazi mediali delle migrazioni, Binotto e Bruno evidenziano tre frame narrativi ricorrenti nel racconto de “lo straniero” [e qui il maschile universale ha purtroppo tutte le ragioni di essere]. Due sono riferibili alla paura che esso genera (criminalità e irregolarità); il terzo al pietismo, che attinge a piene mani al “paternalismo e [allo] sguardo di superiorità etnocentrico di derivazione coloniale”. Si tratta in realtà di due visioni complementari che concorrono a rafforzare un archetipo di alterità: mentre il criminale è fuori, il povero sta sotto. In entrambi i casi, però, esterno al consesso di quelli “come noi”.
Un elemento centrale della costruzione di spazi di co-progettazione è, quindi, la volontà di creare eque condizioni perché le associazioni possano partecipare alla pari degli altri soggetti, anche impegnandosi a rivedere criteri e regolamenti obsoleti o sistematicamente escludenti.
Il continuo aggiornamento delle scelte politiche
Un ultimo punto riguarda la prospettiva futura delle politiche interculturali, che hanno costantemente bisogno di essere aggiornate perché devono adattarsi a un mondo in continua evoluzione.
Le comunità di più vecchia presenza cambiano fisionomia; le nuove generazioni presentano necessità e opportunità, come il diritto di voto e la cittadinanza, diverse da quella dei genitori; nuove comunità con nuovi bisogni fanno la loro comparsa sul territorio (l’ultima, in ordine di tempo, quella composta dallə rifugiatə ucrainə). I Tavoli di comunità — grazie alla loro flessibilità e inclusività — sono un buon strumento per percepire e accompagnare questi percorsi, ma ovviamente non l’unico. Un altro esempio è il Patto Antirazzista approvato nel 2021: uno spazio di ascolto e co-decisione che coinvolge associazioni di comunità e associazioni “alleate” assieme e che mira a creare una più ampia coalizione sociale che verifichi e valuti le politiche cittadine di inclusione.
Infine: l’amministrazione deve essere sempre pronta a immaginare progetti, reti ed eventi che coinvolgano più comunità (in ottica, finalmente, interculturale) e, provando a immaginare le sfide di domani, costruire in anticipo le strutture necessarie per farsi trovare pronti e pronte in caso di imprevisti o di emergenze. Che, come ci hanno dimostrato gli ultimi due anni, non mancheranno.